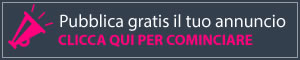Pubertà e adolescenza

La pubertà è il periodo della vita caratterizzato dai profondi cambiamenti morfologici, funzionali e psichici che caratterizzano il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Dura dai 10-16 anni ai 18- 20, con differenze legate a fattori genetici, ambientali, alimentari e di stile di vita. Durante la pubertà si sviluppano gli apparati genitali maschile e femminile, chiamati “caratteri sessuali primari”, con la maturazione delle gonadi (gametogenesi), che rendono l’individuo capace di riprodursi, e i “caratteri sessuali secondari”, che consistono nella manifestazione di notevoli differenze corporee (dimensioni, forma, statura, composizione e funzione di vari organi e apparati del corpo) tra maschi e femmine, compresi genitali esterni, voce, mammelle, peluria, distribuzione di grasso e muscoli. Nel maschio, il primo segno della pubertà è l’aumento di volume dei testicoli, dai 2 ml dell’infanzia a 4 ml. Lo sviluppo del pene si verifica circa 12-18 mesi dopo, ma con tempistiche molto differenti da un ragazzo all’altro, e si associa alle erezioni spontanee mattutine. La prima eiaculazione (spermarca) caratterizza l’avvenuta maturazione sessuale, in media 2 anni e mezzo dopo l’inizio della pubertà. Lo spermarca si verifica mediamente tra i 13 ed i 16 anni. Il primo segno che sta iniziando la pubertà nelle ragazze è la comparsa del bottone mammario, l’abbozzo della mammella (telarca).
Questo può precedere fino a 5 anni il menarca (primo ciclo mestruale), può essere unilaterale per molto tempo e può causare dolore: è tutto normale. Spesso anche i maschi presentano aumento di volume della ghiandola mammaria mono o bilaterale (ginecomastia puberale): il 40-70% dei ragazzi tra i 13 e 16 anni, soprattutto se sovrappeso. Regredisce di solito spontaneamente in 2-4 anni. Il menarca avviene in media a 12anni e mezzo, con ampia variabilità da soggetto a soggetto (9-15 anni). Fisiologicamente fino a 5 anni dopo il menarca i cicli possono essere molto irregolari per quantità e frequenza, per immaturità dell’equilibrio endocrino (cicli anovulatori). La percentuale di cicli anovulatori si attesta intorno al 55% nei primi due anni, per poi scendere al 20% dopo 5 anni .
Alle modificazioni fisiche corrispondono cambiamenti psichici (pulsioni sessuali) e di tipo psicosociale e culturale. Questi ultimi definiscono la condizione di “adolescenza”. Gli adolescenti sono caratterizzati da un proprio modo di pensare e agire peculiare di questa epoca della vita. Ciò dipende da fattori neurobiologici, psicologici, sociologici. Sul piano neuro-biologico, gli studi delle neuroscienze spiegano oggi il perché gli adolescenti trovano difficoltà a dare il giusto valore di rischio ad una determinata azione e sono alla perenne ricerca di emozioni forti: esiste una mancata sincronizzazione tra le aree cerebrali di controllo e di giudizio, chiamate globalmente “controller”, deputate al “decision making” e al controllo comportamentale volontario, in quanto permettono di discernere quali bisogni assecondare, che sono situate nella corteccia frontale e la corteccia cingolata anteriore, e si sviluppano verso i 20-25 anni, e le aree cerebrali del “driver”, che regolano i bisogni fisici e sono le regioni sottocorticali, rappresentate dal sistema limbico, a sviluppo verso i 14-15 anni: queste sono responsabili invece degli impulsi emotivi e della bramosa ricerca e selezione (“craving”) degli stimoli ad alta capacità gratificante ed appagante, rendendo i ragazzi più impulsivi e propensi ad assumere comportamenti rischiosi. Sul piano psicologico, per passare dalla condizione di bambino a quella di adulto, il ragazzo deve sperimentare, mettersi in gioco, confrontarsi con il mondo, inventarsi nuovi modelli e nuovi equilibri emotivi e cognitivi. La ristrutturazione della propria identità, la riflessione su di sé, la consapevolezza del divario tra ideale e reale, possono favorire l’insorgenza di sentimenti di disagio e di malessere. Così, a momenti in cui ci si sente forti e invincibili, spesso se ne alternano altri in cui ci si sente soli, impotenti, timorosi. Sul piano sociologico, un compito dell’adolescente è quello di uscire dal legame di dipendenza che lo lega da bambino ai suoi genitori. Può differenziarsi drasticamente da loro investendo molto nei rapporti di amicizia, oppure il distacco può essere graduale con una serie di manifestazioni di autonomia e contemporanee richieste di attenzione e di protezione. La “disidealizzazione” delle figure genitoriali porta a volte l’adolescente ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti del mondo degli adulti. Il gruppo dei pari (o l’amico del cuore) è idealizzato proprio come lo erano i genitori durante l’infanzia.
Pubertà e adolescenza sono fasi della vita delicatissime, sia dal punto di vista fisico che psichico, noi adulti dobbiamo averne estrema cura e attenzione.
Articoli Salute
- Nei e Melanomi: l'ABCDE
- Zenzero e Limone per una tisana dimagrante
- Acufene Quel fastidioso 'rumore' all’orecchio…
- Cos’è la parodontite? Come riconoscerla
- Salute naturale: Fiori di Bach per animali domestici
- Le complicanze del diabete mellito
- Neonati: prevenire la morte in culla
- Un bicchiere di vino rosso ogni 15 giorni migliora la salute dell’intestino
- Tendinite rotulea sintomi, cause e terapia.
- Osteopatia e sport
- La possibilità di ascoltare ogni sfaccettatura della vita
- Denti ingialliti o macchiati: la soluzione che funziona
- Compiti per le vacanze? Si, ma con metodo Parola d’ordine: vacanze!!!
- Esercizi specifici per dettagli estetici
- Settimana mondiale della tiroide: l’occasione per fare il punto sulla piccola ghiandola preziosa
- Mal di schiena e respirazione: rimedio osteopatico
- Auto. Consigli per un corretto utilizzo dell’aria condizionata
- L’alimentazione nell’adolescenza